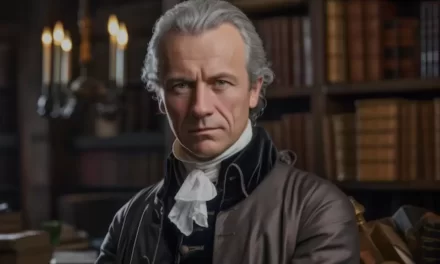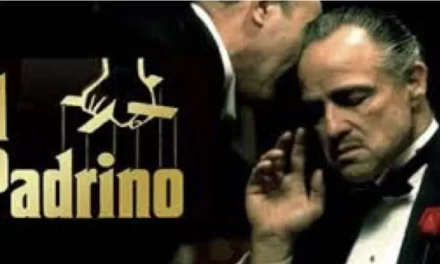EDITORIALE: La frase “E anche questo passerà” rappresenta una sintesi magistrale di millenni di saggezza umana. Essa non è soltanto una consolazione nei momenti di difficoltà, ma un principio guida per affrontare la vita con lucidità e lungimiranza. La sua verità universale si applica tanto alle vicende individuali quanto ai grandi eventi storici, offrendo una prospettiva di speranza e di equilibrio in un mondo in perenne mutamento.
La riflessione sull’impermanenza costituisce un tema centrale nelle principali tradizioni filosofiche, tanto orientali quanto occidentali. La frase “E anche questo passerà”, pur nella sua semplicità, incarna una visione della realtà che ha trovato espressione in numerosi sistemi di pensiero. Nell’antichità greca, Eraclito poneva l’accento sul principio del divenire, affermando pánta rheî “tutto scorre”, ribadendo l’impossibilità di immergersi due volte nello stesso fiume. Tale concezione, che evidenzia l’incessante mutamento dell’esistenza, trova un’eco nella dottrina buddhista dell’anicca, secondo cui nulla è permanente e ogni fenomeno è destinato a dissolversi. Parallelamente, anche la filosofia stoica ha attribuito grande rilievo alla caducità degli eventi e alla necessità di un atteggiamento di equanimità di fronte alla vita. Seneca, nelle sue “Lettere a Lucilio”, ammoniva contro l’attaccamento alle cose terrene, suggerendo che solo la saggezza consente di navigare con serenità il flusso inarrestabile del tempo. Marco Aurelio, nelle sue “Meditazioni”, esprimeva un pensiero affine, esortando alla consapevolezza che ogni evento, per quanto significativo, è destinato a estinguersi nell’oceano dell’eternità. Questo atteggiamento, radicato nella concezione del fato e dell’ordine cosmico, ha permeato la cultura occidentale, ispirando una visione della vita improntata alla moderazione e al distacco emotivo.
Con l’avvento della modernità, il concetto di impermanenza ha assunto connotazioni più articolate, trovando espressione nel pensiero esistenzialista. Friedrich Nietzsche, sebbene noto per la sua teoria dell’eterno ritorno, sottolineava la necessità di accettare il fluire della vita con un atteggiamento dionisiaco, abbracciando la transitorietà come condizione essenziale dell’esistenza. Martin Heidegger, d’altro canto, sviluppò un’analisi ontologica della temporalità, evidenziando come l’essere umano sia strutturalmente proiettato verso il futuro e costretto a confrontarsi con la propria finitezza. In tal senso, la frase “E anche questo passerà” si configura non solo come un monito di saggezza, ma anche come una presa di coscienza dell’ineluttabilità del divenire.
La caducità nella storia e nella politica: ascesa e declino delle civiltà
La consapevolezza della transitorietà ha sempre giocato un ruolo fondamentale nell’analisi storica e politica. L’idea che nessuna potenza, per quanto grandiosa, possa sfuggire al ciclo di ascesa e declino è un principio che permea la storiografia da Erodoto a Gibbon. L’Impero Romano, per esempio, rappresenta un caso emblematico di grandezza effimera: nato da una città-stato e divenuto la forza egemonica del Mediterraneo, ha infine ceduto alle pressioni interne ed esterne, lasciando spazio a nuove entità politiche. La frase latina “sic transit gloria mundi” esprime con forza questa ineluttabilità, ricordando che ogni gloria terrena è destinata a svanire. Analogamente, il Rinascimento europeo ha visto fiorire e decadere stati e dinastie nel giro di pochi secoli. La caduta della Repubblica di Firenze, la crisi dell’Impero Spagnolo e la rivoluzione francese sono esempi di come la stabilità politica sia solo un’illusione temporanea. Anche la riflessione di Lincoln nel 1859, nel contesto della Guerra Civile Americana, con la sua frase “ e anche questo passerà” pronunciata Nel discorso davanti alla Società Agricola dello Stato del Wisconsin manifesta una duplice valenza: da un lato, la consapevolezza che le tensioni tra Nord e Sud avrebbero trovato una risoluzione; dall’altro, il desiderio che la prosperità costruita attraverso la cultura e il lavoro non fosse effimera, ma potesse radicarsi stabilmente. In epoca contemporanea, la rapidità con cui avvengono i mutamenti geopolitici e tecnologici rende ancora più evidente la verità contenuta nella frase “E anche questo passerà”. L’ascesa e il declino di superpotenze, le crisi economiche, l’instabilità delle istituzioni democratiche dimostrano che nessun assetto sociale o politico può considerarsi definitivo. Tuttavia, se da un lato la consapevolezza della caducità può generare un senso di precarietà, dall’altro essa può costituire un potente incentivo al rinnovamento e all’innovazione. L’instabilità, infatti, è il motore del progresso: senza il riconoscimento della transitorietà, non vi sarebbe spazio per il cambiamento.
Implicazioni psicologiche e sociologiche della transitorietà
Dal punto di vista psicologico, la frase “E anche questo passerà” assume una funzione catartica e terapeutica. Nella psicoanalisi freudiana, il concetto di elaborazione del lutto è strettamente connesso alla capacità di accettare la perdita come parte integrante della vita. Sigmund Freud sosteneva che il dolore derivante dalla separazione o dalla scomparsa di un oggetto d’amore poteva essere mitigato solo attraverso il riconoscimento della sua inevitabilità. In questa prospettiva, l’impermanenza non è un fardello, bensì un’opportunità per la crescita interiore. Le neuroscienze hanno evidenziato che l’accettazione della transitorietà gioca un ruolo fondamentale nella regolazione delle emozioni. Studi recenti hanno dimostrato che individui che sviluppano una maggiore tolleranza all’incertezza tendono a sperimentare livelli inferiori di ansia e depressione. La mindfulness, pratica meditativa di derivazione buddhista, si basa proprio su questo principio: osservare il fluire dei pensieri e delle emozioni senza attaccamento permette di affrontare le difficoltà con maggiore resilienza. Sul piano sociologico, la percezione della caducità influenza profondamente le dinamiche collettive. Movimenti sociali, correnti artistiche e innovazioni culturali emergono e si dissolvono in un processo ciclico che ricorda le teorie di Arnold Toynbee e Oswald Spengler sulla nascita e il declino delle civiltà. La globalizzazione ha accelerato tale processo, rendendo le trasformazioni ancora più rapide e pervasive. Tuttavia, proprio nella consapevolezza della transitorietà si trova la chiave per costruire un futuro più consapevole e sostenibile. Accettare che nulla sia eterno non significa rassegnarsi, ma comprendere che ogni crisi contiene in sé il seme della rinascita.