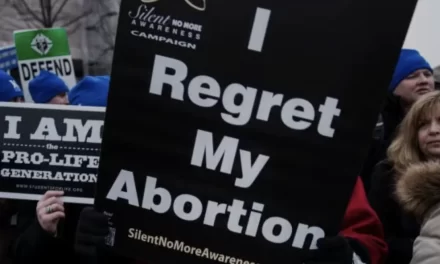Le sfide che l’Europa deve affrontare richiedono un nuovo protagonismo fondato sulla diplomazia culturale e l’intelligenza integrale, un approccio integrato e una visione strategica chiara. Solo attraverso la cooperazione e il coordinamento delle politiche a livello europeo sarà possibile costruire un futuro di prosperità e sicurezza. È tempo che l’Europa riscopra il suo ruolo di faro di civiltà e innovazione, valorizzando la libertà, la democrazia, la giustizia sociale e l’uguaglianza sostanziale.
La situazione geopolitica attuale può essere per il vecchio continente europeo una sonora sveglia, una reazione dal torpore immobilista. Nietzsche ci invita a non temere le sfide: “Ciò che non ci uccide ci rende più forti”, un monito che l’Europa farebbe bene a ricordare nel perseguire i propri obiettivi. Già lo scorso 9 settembre 2024, Mario Draghi ha presentato, in una conferenza congiunta con la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il rapporto intitolato “Il futuro della competitività europea”. Questo documento, rappresenta un tentativo autorevole e prezioso di definire una strategia coerente e strutturata per affrontare le sfide globali che l’Unione Europea deve fronteggiare nel prossimo decennio. Le tensioni geopolitiche, la transizione energetica e l’accelerazione tecnologica rendono necessaria una profonda revisione delle politiche economiche, industriali e sociali dell’Europa. Il rapporto non si limita a fornire una diagnosi dello stato attuale, ma propone un’agenda articolata volta a promuovere la competitività sostenibile, l’innovazione tecnologica e la sicurezza strategica. È necessaria una visione integrale dell’Europa considerando il bene comune sopra ogni interesse particolare. In questa prospettiva, dobbiamo fronteggiare le tensioni internazionali richiedono uno sforzo collettivo ispirato da una visione di lungo termine e da un profondo senso di responsabilità storica. Come diceva anche John Stuart Mill, “Il progresso umano non avviene mai senza la lotta e il confronto delle idee”, sottolineando l’importanza di un dialogo costante e di una riflessione condivisa sul futuro.
Il punto di partenza – un nuovo paesaggio per l’Europa
Sebbene l’Europa disponga delle risorse e delle competenze necessarie per competere a livello globale, il rallentamento della produttività e il divario di innovazione rispetto a Stati Uniti e Cina rappresentano ostacoli significativi. Negli ultimi due decenni, la crescita economica europea è stata sistematicamente inferiore rispetto a quella dei suoi principali competitor, con un impatto negativo sul benessere dei cittadini europei. Secondo i dati Eurostat, gli Stati Uniti rappresentano il principale partner commerciale dell’UE per l’esportazione di merci e il secondo per l’importazione. Nel 2023, l’UE ha registrato un surplus commerciale di 157 miliardi di euro in merci con gli Stati Uniti. Tuttavia, nel settore dei servizi, la situazione appare diversa: nello stesso anno, l’UE ha registrato un deficit di 109 miliardi di euro nei confronti degli Stati Uniti. Le cause di questa situazione sono molteplici: la globalizzazione ha trasformato il panorama economico mondiale, la crisi energetica ha esposto la vulnerabilità delle infrastrutture energetiche europee e i cambiamenti geopolitici hanno ridefinito le priorità strategiche dell’Unione. Come sottolineava Aristotele, “la politica è l’arte di garantire la felicità umana”, e in questo contesto l’aumento della produttività non è solo un obiettivo economico, ma un elemento essenziale per preservare la coesione sociale e il benessere collettivo. L’Europa deve reagire rilanciando la crescita europea con 3 azioni concrete:
- Correggere il rallentamento della crescita della produttività, colmando il divario di innovazione rispetto a Stati Uniti e Cina. L’innovazione deve diventare il motore della crescita europea, attraverso lo sviluppo di tecnologie rivoluzionarie e l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei settori produttivi chiave;
- Ridurre i costi energetici, accelerando la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e adottando un approccio tecnologicamente neutrale;
- Rafforzare la sicurezza strategica e ridurre le dipendenze, promuovendo una politica industriale coordinata e sviluppando una capacità di difesa autonoma.
Come ammoniva Seneca, “Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare”. Allo stesso modo, l’Europa deve chiarire la propria rotta, ponendo la competitività sostenibile e l’inclusione sociale al centro delle sue politiche. La storia è un processo razionale, e in questo processo l’Europa deve saper imparare dai suoi errori per costruire un futuro migliore.
Il commercio UE-USA e le sfide tariffarie
Un elemento cruciale delle relazioni transatlantiche riguarda il commercio di beni e servizi. Gli Stati Uniti sono stati il partner più importante dell’UE per l’esportazione e l’importazione di servizi nel 2023. La profondità di queste relazioni è tuttavia minacciata dalla possibilità di una politica tariffaria più aggressiva da parte degli Stati Uniti. Se gli Stati Uniti applicassero dazi sui prodotti europei, i prezzi aumenterebbero, riducendo la competitività delle merci dell’UE sul mercato americano. Di tutta risposta, l’UE potrebbe reagire imponendo controdazi, creando una spirale di azioni e reazioni. Ma come ricordava Adam Smith, “Ogni tassa che scoraggia l’importazione scoraggia anche l’esportazione”, sottolineando i pericoli di un approccio protezionistico. Le catene di approvvigionamento profondamente integrate rendono queste misure non solo dannose per l’Europa, ma anche controproducenti per gli stessi Stati Uniti. In questo scenario, l’incertezza commerciale potrebbe spingere molte imprese a posticipare gli investimenti, con un impatto negativo sulla crescita economica. L’UE, tuttavia, dispone di strumenti per difendersi. Tra questi, la possibilità di presentare reclami all’Organizzazione mondiale del commercio o di adottare contromisure attraverso lo strumento anti-coercizione. Come ultima risorsa, l’UE potrebbe imporre restrizioni agli investimenti e ai finanziamenti, garantendo comunque il rispetto delle regole internazionali.
Decarbonizzazione, competitività e sicurezza strategica
La transizione energetica è un’altra priorità fondamentale. La decarbonizzazione offre all’Europa un’opportunità unica per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e assumere un ruolo di leadership globale nelle tecnologie pulite. In tale prospettiva di ecologia integrale sembra necessario ridurre i prezzi dell’energia, promuovendo l’integrazione delle energie rinnovabili e del nucleare nel mix energetico europeo, accelerare la diffusione delle infrastrutture per l’idrogeno e la cattura del carbonio, semplificando le procedure di autorizzazione per i progetti energetici, adottare un approccio tecnologicamente neutrale, supportando tutte le soluzioni disponibili per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Come ricordava Eraclito, “Nulla è permanente, tranne il cambiamento”. L’Europa deve abbracciare questa verità e adattarsi rapidamente ai mutamenti del contesto energetico globale valorizzando la propria sicurezza strategica. Quest’ ultima è una componente essenziale della competitività europea. La pandemia e le tensioni geopolitiche hanno svelato la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento europee, soprattutto nel settore delle materie prime critiche e dei semiconduttori. In tale prospettiva è necessario creare una piattaforma europea per le materie prime critiche, per coordinare gli acquisti e negoziare accordi strategici con i paesi produttori, promuovere la produzione locale di semiconduttori, rafforzando le capacità industriali europee e sviluppare una politica economica estera, finalizzata a garantire la sicurezza delle risorse strategiche attraverso partenariati internazionali. Hannah Arendt ci ricorda inoltre che “il potere nasce dall’azione collettiva”, e solo attraverso la cooperazione gli Stati membri potranno affrontare le sfide globali. In questo contesto, l’Europa deve agire con determinazione per proteggere il proprio futuro di democrazia e dignità.