Arthur Schopenhauer ha lasciato un segno indelebile nella storia del pensiero con il suo pessimismo radicale, una lente attraverso cui ha interpretato il mondo, l’esistenza e le relazioni umane. Tra i suoi temi più affilati vi è quello dell’isolamento degli uomini intelligenti, non come scelta romantica o d’élite, ma come condizione inevitabile. Per il filosofo, infatti, la solitudine non è un accidente dell’intellettuale, ma il suo destino.
La prima ragione è di ordine intellettuale: la maggior parte degli uomini si muove su un piano di superficialità, dominato da bisogni immediati, convenzioni e desideri che ne determinano le azioni e i pensieri. Chi possiede un’intelligenza superiore, invece, non solo si affaccia su un livello più profondo della realtà, ma è anche in grado di smascherarne le illusioni. Questo crea una frattura insanabile con la massa, che non comprende chi pensa diversamente e, per istinto di conservazione, lo emargina o lo ridicolizza. La società tollera l’eccentricità solo quando è innocua; quando invece scuote le fondamenta delle convinzioni comuni, diventa scomoda e deve essere isolata.
Ma l’isolamento delle persone intelligenti non è solo frutto di un’esclusione imposta dall’esterno: è anche una condizione che esse stesse cercano, quasi come difesa. Chi è capace di vedere oltre la cortina di fumo delle banalità quotidiane prova fastidio per la conversazione vuota, per le dispute insignificanti, per la mediocrità eretta a norma sociale. Lo stare in mezzo agli altri diventa un esercizio di pazienza o di rassegnazione, e alla lunga, la solitudine si rivela una condizione preferibile, se non necessaria.
A questo si aggiunge un aspetto più inquietante: l’intelligenza è una condanna alla sofferenza. L’uomo comune si rifugia nella routine, nei piaceri effimeri, nelle distrazioni che lo proteggono dall’angoscia esistenziale. L’uomo intelligente, invece, è più esposto alla consapevolezza della caducità della vita, della vanità delle ambizioni, della fragilità delle relazioni umane. Non a caso Schopenhauer individua nell’intelligenza un fattore di infelicità: più si comprende, più si soffre. E chi soffre, spesso, si isola.
Ma c’è di più. La società non solo ignora chi è superiore per capacità di pensiero, ma talvolta lo osteggia apertamente. L’umanità, dice Schopenhauer, è dominata da una forma di inerzia mentale che la porta a diffidare delle idee nuove e di chi le propone. La mediocrità è rassicurante, perché non pone domande e non disturba il quieto vivere. L’intelligenza, al contrario, è una provocazione costante, un elemento di disturbo che mina le certezze acquisite. Così, l’isolamento degli uomini intelligenti diventa anche una forma di difesa della società stessa, che respinge chi rischia di metterne in discussione l’ordine precostituito.
Eppure, la solitudine dell’uomo superiore non è solo un destino amaro: è anche la condizione necessaria per il pensiero libero. Schopenhauer, influenzato dalle filosofie orientali, vede nella solitudine non un peso da sopportare, ma una forma di emancipazione. L’intellettuale, se accetta il proprio isolamento, si libera dalla necessità del riconoscimento altrui e trova nella propria interiorità una fonte di appagamento più autentica di qualsiasi relazione superficiale. La sua solitudine diventa così non solo una condizione esistenziale, ma una scelta filosofica: il rifiuto della banalità per l’abbraccio della contemplazione.
In questa prospettiva, l’intelligenza si rivela non solo un dono, ma anche una condanna. Chi vede più lontano, cammina inevitabilmente da solo. E forse, proprio in questo isolamento, trova la propria vera libertà.





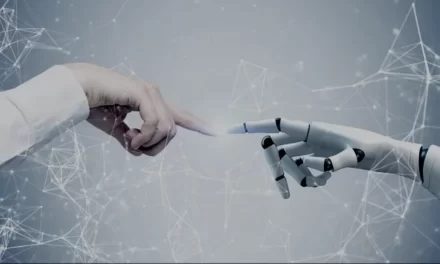







L’articolo coglie una verità profonda dal punto di vista di un filosofo post illuminista. Dalla foto mi sembra distinguere gli interpreti di Alice e Mattia, protagonisti del film “La solitudine dei numeri primi” tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Giordano a me particolarmente caro.
Condivido tutto. Grande cultura. Continuate così.