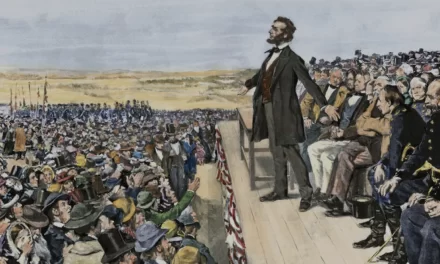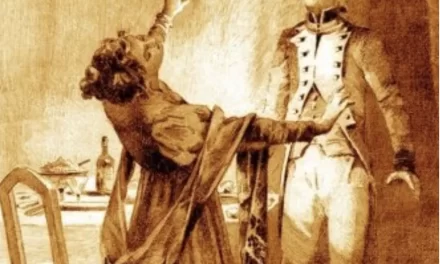Il 4 aprile 1944 è una data che dovrebbe vibrare nella coscienza collettiva italiana con la stessa forza del 27 gennaio, del 25 aprile, del 2 giugno. In quel giorno, a Trieste, entrava in funzione il forno crematorio della Risiera di San Sabba, l’unico campo di sterminio nazista in Italia. Un luogo pensato, costruito e utilizzato non solo come campo di detenzione, ma come macchina della morte.
Oltre 5.000 persone furono uccise in quel complesso industriale trasformato in lager: ebrei, partigiani, sloveni, croati, oppositori politici, sacerdoti, operai. Lì venivano interrogati, torturati, giustiziati e inceneriti i corpi. Nessun bisogno di deportarli altrove. L’orrore, per la prima volta, accadeva in casa nostra.
“La memoria è il dovere dei vivi nei confronti dei morti,
Alfonso Bruno
e l’ultima speranza contro il ritorno dell’indicibile.”
Un lager in terra italiana
La Risiera di San Sabba, prima della guerra, era uno stabilimento per la lavorazione del riso. Con l’occupazione nazista della Venezia Giulia e l’istituzione dell’OZAK (Zona d’Operazioni del Litorale Adriatico), divenne un luogo di detenzione e smistamento. Ma dal 1944, con l’arrivo del comandante della Gestapo Odilo Globocnik, vi si installò un forno crematorio, progettato appositamente per eliminare le tracce degli omicidi. Fu l’unico forno del genere costruito dai nazisti nel territorio della penisola.
Non si trattava più solo di deportazione o oppressione: era sterminio organizzato. Un lager con camere di tortura, celle di isolamento, e soprattutto una brutalità pianificata. La Risiera era un’appendice diretta di Auschwitz, con un suo metodo e una sua tragica efficienza.
Il silenzio dopo la liberazione
Terminata la guerra, il destino della Risiera non fu quello di Auschwitz o Dachau. Non divenne subito un simbolo della Shoah, ma rimase per anni circondata da silenzio, rimozione, vergogna. Trieste, città di confine, di identità incrociate e conflitti politici post-bellici, si trovò a lungo a non poter o voler affrontare quel passato.
Fu solo nel 1965 che la Risiera venne dichiarata monumento nazionale. Solo nel 1975 fu istituito il Museo della Risiera di San Sabba. Solo nel 1976 si celebrò il primo processo pubblico ai carnefici del lager, ma i principali responsabili erano fuggiti o morti.
Il tempo ha impiegato decenni per restituire alle vittime il diritto alla memoria.
Non c’è futuro senza memoria
Primo Levi
La Risiera ci parla, anche se le sue mura sono mute. Parla ai vivi con la voce dei morti. Ci dice, innanzitutto, che l’orrore non è mai lontano. Non serve andare a cercarlo nei campi della Polonia o nei deserti della memoria. L’orrore può nascere accanto a noi, nella casa di fronte, nella caserma, nella scuola, nei silenzi della buona società. Può indossare le nostre stesse divise, parlare la nostra lingua, camminare con il passo dell’“ordine”. La Risiera non fu solo una periferia dell’orrore europeo: fu cuore pulsante di una ferocia tutta nostra, consumata in una città italiana, contro uomini e donne italiani, slavi, ebrei, oppositori. È una realtà che ci costringe a guardare in faccia la nostra responsabilità. Non fummo solo spettatori. In certi momenti, fummo complici. In altri, persino carnefici.
Ma la Risiera grida anche qualcosa di più profondo: il fascismo aprì le porte al nazismo. Non ci sono zone grigie quando si parla di totalitarismo, non esistono mezze misure quando si uccide la libertà. Le leggi razziali del 1938 non furono un inciampo tecnico. Furono l’inizio di una discesa morale, il sigillo legale della disumanizzazione. La repressione dei dissidenti, la violenza contro gli oppositori, il servilismo verso Hitler non furono deviazioni, ma scelte precise, che crearono l’ambiente in cui fu possibile bruciare corpi nella notte e farli sparire in cenere.
E poi c’è l’ultima, terribile, urgente verità: la memoria non è un dovere del passato, ma un’urgenza del presente. La Risiera non è un museo da visitare una volta all’anno, non è un’anticaglia da relegare ai libri. È una ferita viva, una spina nella carne della nostra democrazia. Serve a ricordarci che nulla – nulla – è garantito: né la libertà, né i diritti, né la pace. Ogni volta che si insinua il germe del disprezzo, dell’indifferenza, del razzismo, ogni volta che si rispolverano le ideologie della forza, della “razza”, del nemico da abbattere, la Risiera ci ammonisce. Non con la voce dei politici, ma con le grida soffocate di chi lì dentro è stato annientato.
Camminare oggi tra le sue mura significa entrare in un tempio ferito della coscienza, e uscirne trasformati. Non più solo spettatori, ma testimoni. Perché ricordare non è conservare: è scegliere da che parte stare. Anche oggi. Anche adesso.
La responsabilità di ricordare
Ricordare la Risiera di San Sabba il 4 aprile di ogni anno non è solo un dovere storico. È un atto di giustizia verso le vittime. È una preghiera laica e collettiva per dire che non dimenticheremo. E che quando le ideologie del dominio tornano a farsi strada – sotto altre forme, con altri linguaggi – noi sapremo riconoscerle e dire di no.
Perché la Risiera non è solo un monumento: è una coscienza.
E la coscienza, come la libertà, non va mai in vacanza.